I tempi verbali servono a collocare un’azione nel presente, nel passato o nel futuro e a mostrare come si svolge nel tempo. Nella pratica, intrecciano tempo, modo e talvolta l’aspetto (azione compiuta, abituale, in corso). Questa guida ti aiuta a riconoscerli e a usarli con sicurezza.
Guida rapida e pratica: differenza tra tempi semplici e composti, uso degli ausiliari essere/avere, tempi principali dell’indicativo, congiuntivo e condizionale, tanti esempi e consigli per evitare errori tipici e scegliere il tempo giusto in base al contesto.
Quali sono i tempi semplici e composti?
I tempi semplici hanno una sola parola (parlo, scrivevo, partirò). I tempi composti uniscono un ausiliare (essere/avere) al participio passato (ho parlato, sono arrivata, avremo finito), così esprimono anteriorità o completamento rispetto a un altro momento.
Quando si usano essere e avere come ausiliari?
I verbi ausiliari essere e avere formano i tempi composti: ho parlato, sono uscita. In genere, i verbi transitivi usano avere (ho letto il libro). Molti intransitivi di movimento o cambiamento di stato preferiscono essere (sono andato, è diventata). I verbi riflessivi vogliono essere (mi sono alzato). Nei composti con essere, il participio concorda con il soggetto; con avere, di norma resta invariabile.
Punti chiave sui tempi
- I tempi si dividono in semplici e composti.
- I composti usano gli ausiliari essere o avere.
- Col composto con essere, il participio concorda con il soggetto.
- Ogni modo verbale ha propri tempi (indicativo, congiuntivo, ecc.).
- Il valore temporale dipende dal contesto e dall’aspetto.
- Il trapassato colloca un’azione prima di un passato.
Come funzionano i tempi dell’indicativo?
L’indicativo racconta fatti considerati reali o molto probabili.
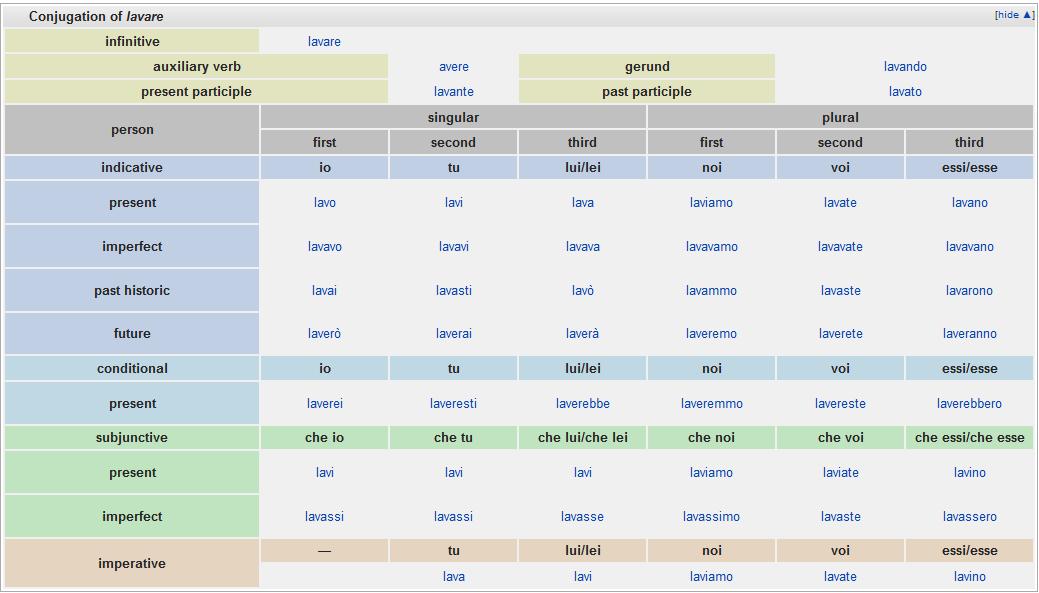
Alterna tempi «di sfondo» e «di primo piano», e combina durata, conclusione e ordine degli eventi per rendere il testo scorrevole e chiaro.
I tempi verbali collocano l’evento rispetto al momento dell’enunciazione.
Tra i tempi del racconto, passato prossimo e passato remoto si alternano in base a registro, area e genere testuale. Il passato prossimo domina nella lingua quotidiana; il remoto è frequente nella narrazione letteraria e in alcune varietà regionali.
- Presente. Descrive ciò che avviene ora o in modo generale: «Studio ogni giorno». Può dare vivacità al racconto: «Arrivo, apro la porta e…». È utile anche per verità sempre valide.
- Imperfetto. Dipinge sfondi, abitudini e azioni protratte: «Da piccolo giocavo in cortile». Può esprimere cortesia o irrealtà nel presente: «Volevo chiedere un’informazione».
- Passato prossimo. Azione compiuta e vicina al presente: «Ho finito il lavoro». Collega il risultato all’oggi (effetto percepibile). In molte aree, sostituisce il remoto nel parlato.
- Passato remoto. Evento concluso e collocato in un passato «chiuso»: «Scrisse una lettera». Ricorre spesso nella narrazione storica o letteraria e in alcune varietà regionali.
- Trapassato prossimo. Indica un’azione avvenuta prima di un’altra già passata: «Quando arrivai, avevano già cenato». Aiuta a mantenere l’ordine temporale degli eventi.
- Futuro semplice. Proietta avanti nel tempo: «Domani partirò». Esprime anche ipotesi o probabilità sul presente: «Sarà a casa, immagino».
- Futuro anteriore. Indica un futuro precedente a un altro futuro: «Quando arriverai, avrò terminato». Può rendere un’ipotesi sul passato: «Avrà dimenticato il telefono».
Nel racconto complesso, usa il trapassato prossimo per retrocedere di un passo nel tempo, poi torna al passato prossimo o remoto per riprendere la linea principale: la coerenza temporale guida il lettore.
Perché esistono congiuntivo e condizionale?
Servono a esprimere incertezza, opinione, desiderio, ipotesi o conseguenza.

Il congiuntivo marca la soggettività; il condizionale indica potenzialità o cortesia e costruisce il periodo ipotetico.
Tempi del congiuntivo
Il congiuntivo ha presente, passato, imperfetto e trapassato. «Credo che sia vero» (presente); «Temevo che arrivasse tardi» (imperfetto). Si usa dopo verbi di opinione, dubbio, desiderio e in alcune locuzioni: è un segnale di incertezza o valutazione.
Tempi del condizionale
Il condizionale ha presente e passato: «Verrei volentieri», «Sarebbe piaciuto a tutti». Esprime cortesia («Potrebbe aspettare?»), attenua richieste e costruisce ipotesi con se: I tipo (realtà), II e III tipo (irrealtà o impossibilità), con tempi in combinazione coerente.
Passato prossimo o passato remoto: quale scegliere?
Dipende da contesto, varietà d’italiano, distanza temporale percepita e genere testuale. Nel parlato, prevale spesso il passato prossimo; nella narrazione letteraria, il remoto è molto produttivo. L’importante è restare coerenti all’interno del testo.
Nell’italiano contemporaneo il passato prossimo prevale nel parlato, il remoto nella narrazione letteraria.
Quali errori evitare con i tempi?
Molti errori nascono dalla fretta o dal copiare schemi non adatti al contesto. Con pochi accorgimenti, il tuo testo risulterà più naturale e scorrevole.
- Mischiare tempi senza criterio. Mantieni una linea temporale coerente: se inizi in passato prossimo, resta su quel piano o segnala il cambio con il trapassato.
- Dimenticare gli ausiliari corretti. Alcuni verbi ambivalenti cambiano ausiliare con sfumature diverse: «vivere ha vissuto/è vissuto». Verifica il significato che vuoi rendere.
- Trascurare la concordanza. Con essere, il participio concorda con il soggetto: «le ragazze sono arrivate». Con avere, di norma non concorda.
- Usare il futuro al posto del presente. Nel parlato informale, spesso il presente è più naturale: «Vengo tra poco», non sempre «verrò tra poco».
- Forzare il congiuntivo o evitarlo sempre. Sceglilo quando serve (opinioni, dubbi, desideri) e usa l’indicativo per fatti: l’equilibrio aiuta chiarezza e stile.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra tempo e modo?
Il tempo colloca l’azione (presente, passato, futuro); il modo indica l’atteggiamento del parlante verso l’azione (realtà, ipotesi, desiderio). Ogni modo ha diversi tempi.
Quando si usa il trapassato prossimo?
Quando un evento è precedente a un altro passato: «Quando arrivai, avevano già chiuso». Serve a ordinare con chiarezza gli avvenimenti nella narrazione.
Il congiuntivo è sempre obbligatorio?
No: dipende dal verbo reggente e dalla frase. Dopo credere, pensare, temere, desiderare, è di norma preferibile; ma per fatti certi e dichiarati si usa l’indicativo.
Come scelgo tra passato prossimo e remoto?
Valuta contesto, registro e varietà d’italiano. Nel parlato è comune il passato prossimo; nella narrazione letteraria e in alcune aree è frequente il remoto. Sii coerente nel testo.
Che cosa cambia con essere o avere nei composti?
L’ausiliare selezionato influisce su significato e concordanza. Con essere il participio concorda col soggetto; con avere di norma no. I riflessivi vogliono essere.
In sintesi rapida
- Distingui tra tempi semplici e composti, e usa correttamente gli ausiliari.
- Indicativo per i fatti; congiuntivo per incertezza; condizionale per ipotesi e cortesia.
- Con essere, il participio concorda con il soggetto; con avere di norma no.
- Passato prossimo o remoto: scegli in base a registro, contesto e coerenza.
- Evita salti temporali: mantieni una linea chiara e segnala i cambi.
Imparare a riconoscere e combinare i tempi non è un esercizio mnemonico, ma un modo per comunicare meglio. Parti dalle situazioni concrete, confronta esempi e rileggi i tuoi testi cercando coerenza, chiarezza e ritmo.
Con un po’ di ripasso mirato e attenzione alle strutture ricorrenti, vedrai i tempi come alleati. Sperimenta, ascolta buoni modelli e affina la scelta in base a scopo, pubblico e registro: la padronanza cresce con l’uso consapevole.
